A Ouagadougou la vita sembra scorrere piacevolmente, come sempre, ma è solo una tranquillità di facciata. Il nord e l’est del Paese sono finiti ostaggio del terrorismo jihadista, che si sta espandendo ormai anche a sud-ovest. Il governo e l’esercito hanno perso il controllo di vaste regioni dove si respira un’atmosfera di vera e propria guerra. E la capitale del Burkina – un tempo nazione pacifica e accogliente – appare sempre di più un’enclave assediata dal caos e dell’instabilità.
di Piero Sunzini
A cena con i miei giovani amici è sempre piacevole. Ristorante all’aperto, cibo buono, ottime conversazioni. È il Burkina Faso accogliente, socievole e plurale che ho conosciuto e che ancora amo. A Ouagadougou sembra che la vita scorra normalmente. Gli effetti del Covid non sono ancora evidenti nelle dinamiche cittadine, gli attentati terroristici del nord e dell’est del Paese si leggono sui giornali e la popolazione locale ne è coinvolta direttamente solo ai semafori, quando si evidenziano gli sfollati che chiedono l’elemosina.
Il rituale di benvenuto
Sono con Omar fuori dal ristorante, in attesa degli altri. All’arrivo di Ibrahim e Vincent comincia la plaisanterie: il rituale di benvenuto. È sempre esilarante. Questa forma di saluto si basa sulla reciproca presa in giro, assolutamente bonaria, per le diverse appartenenze alle comunità del Paese. Diventa straordinario quando s’incontrano due “cugini di plaisanterie”: di gruppi differenti ma che, fin dal passato remoto, hanno avuto legami stretti e non sempre cordiali. È questo il caso.“Buona sera al mio giovane servo” è il saluto gioioso di Omar. “Se il mio bisnonno non avesse messo incinta la tua principessa non saresti mai nato” è il riscontro di Ibrahim, condito da vigorose strette di mano e grandi sorrisi che terminano solo alla vista di Vincent, quando l’atmosfera si fa subito seriosa: “Non hai portato il cane?” domanda Omar – alludendo al “vezzo” di mangiare i cani della comunità di Vincent – e subito nuove risate e abbracci calorosi. Il dialogo allegro continua a tavola, il clima rimane cordiale e ridanciano.

Il cambiamento dei Peul
A tavola la conversazione cade su un tema particolarmente caldo: i Peul, una delle popolazioni maggiormente presenti in Africa occidentale. Quella che da secoli pratica il pastoralismo nelle zone più impervie dell’Africa occidentale, dove le condizioni climatiche rendono la vita difficile per gli uomini, gli animali ma anche per le piante; che riesce a generare reddito dall’allevamento semi-nomade del bestiame; che ha convissuto in pace con tutte le popolazione della fascia saheliana, dal Senegal al Sudan, al netto di conflitti locali per l’utilizzo della terra con le comunità contadine stanziali; che pur professando l’islam non ha mai avuto posizioni estremiste ed intolleranti. Oggi non è più così. Negli ultimi anni, la penetrazione jihadista nel nord del Burkina Faso è forte e significativa. È molto impattante sul territorio. I Peul hanno stretto alleanze, più o meno strategiche, con i gruppi terroristi.
Le ragioni sono diverse. Da una parte, sono “obbligati” da intimidazioni e provocazioni quotidiane: furti di bestiame, attentati, aggressioni e violenze alle donne, fino a omicidi anche per futili motivi. Le minacce verso le singole famiglie si placano, il più delle volte, solamente quando i giovani decidono di “arruolarsi” con le bande terroristiche: è lo strumento più efficace per garantire l’incolumità dei villaggi e delle famiglie d’appartenenza. Dall’altra, in un contesto socioeconomico sempre più difficile e peggiorato dai repentini cambiamenti climatici, molti giovani intravedono nell’arruolamento la strada principale per garantirsi un salario con il quale uscire dalla miseria. C’è una forte complicità con i gruppi armati, dunque, da parte dei giovani Peul. Quello che stupisce, però, è il loro profilo comportamentale che non è sempre in linea con la narrativa mainstreaming che lo descrive. Molti provengono dalle scuole coraniche, ma un numero sempre più crescente è scolarizzato e fa una scelta “razionale” e convinta; non disdegna nemmeno la convivenza con altri giovani che provengono dalle fila del banditismo locale.

Territorio minato
Non è più un fenomeno che riguarda solamente le enclave dei grandi villaggi abitati prevalentemente dai Peul, nel Sahel burkinabè. L’estremo Nord si trova in questa situazione ed è quasi isolato dal resto del Paese, anche fisicamente. A Djibo, nella Regione del Sahel, non si accede più né da Est, da Ouahygouya – Regione Nord; né da Ovest, da Dori, la città sulla direttrice di collegamento con il Niger. Non c’è sicurezza, nemmeno di giorno. Ci sono gruppi armati che controllano questi assi stradali e che intercettano a loro piacimento chiunque vi transiti “non autorizzato”. Si arriva solamente da Sud, con non poche difficoltà e molti rischi. Superato Kongoussi, all’altezza di Yalka la strada diventa una pista. In più tratti i gruppi terroristi hanno collocato delle mine che hanno già fatto molti danni. I locali ormai, quando possono, la percorrono principalmente a piedi o in bicicletta. Il rischio per le moto e le vetture di saltare in aria è molto elevato. Per questa ragione sono state fatte delle deviazioni dall’arteria principale che sconfinano nella savana, là dove è possibile, per mettere in sicurezza il transito dei veicoli a motore. Non è sempre sufficiente.
Il 2 marzo scorso un’autoambulanza che aveva imboccato una di queste deviazioni è stata completamente distrutta da un’esplosione. Sono state minate anche le vie traverse. È successo dopo Gaskinde, prima d’arrivare a Yalka, in direzione sud. Stava andando all’ospedale di Ouagadougou. Sei morti: una donna incinta, accompagnata dal marito, due amiche e da una bambina di sei anni. Ha perso la vita anche l’autista.

Una realtà di guerra
Questa tipologia d’eventi è solo la punta dell’iceberg. Continuano incessantemente le azioni d’intimidazione e non è strano che ne siano destinatari anche operatori delle organizzazioni umanitarie, di agenzie delle Nazioni Unite, di ONG internazionali o associazioni locali di volontariato. Per avere agibilità operativa per la distribuzione di viveri o di kit sanitari, devono applicare codici comportamentali da zona di guerra. Il Nord del Burkina Faso è una realtà di guerra, non dichiarata ma comunque guerra. Con i suoi morti, le sue rappresaglie, i suoi tradimenti, con la scomparsa dei modelli di convivenza civile. Ci sono stati “rapimenti a tempo”, di 2-3 ore. Bloccata la macchina, interrogati, perquisiti, controllati i documenti, rapinati di dossier di lavoro, di fatto schedati … questi operatori sono stati poi rilasciati con avvertimenti precisi ed un decalogo comportamentale da rispettare. L’esercito e la polizia locale sono spesso impotenti difronte a questa realtà.
“Non ho voglia di parlare dei Peul. La maggior parte è connivente con i gruppi terroristi. Non voglio andare oltre, non voglio arrivare a dire che spesso sono gli attori principali di azioni sanguinarie”. Le parole inequivocabili di Ibrahim cambiano il clima della cena, in maniera inaspettata. Nemmeno l’orchestrina che suona “jerusalem”, la hit del momento, e i passi di danza mimati dai nostri vicini di tavolo, che con sorrisi e schiocchi delle dita ne seguono il ritmo gioiosamente, riescono a mutare l’umore che si è appropriato del nostro tavolo.
Il Burkina Faso è come Giano Bifronte. A Ouagadougou resiste il volto ridanciano, dove difficilmente si percepisce l’esistenza di quello cupo di altre, tante, realtà del Paese: non solo il Nord ma ormai una buona parte dell’Est è coinvolto in dinamiche di guerra guerreggiata. Ultimamente segnali inequivocabili arrivano anche dal Sud-ovest. Gli interventi realizzati dal governo locale e dalla comunità internazionale non hanno sortito i risultati sperati.
(Piero Sunzini)
Tamat, una ong italiana accanto alla popolazione del Burkina
Un tempo il Burkina Faso era un luogo considerato sicuro, pacifico, tra i più accoglienti dell’Africa. La proverbiale ospitalità del suo popolo e l’attivismo della sua società civile creavano un terreno fertile, vitale, in cui si erano insediate numerose ong e associazioni di solidarietà internazionale. Con lo scoppio dell’instabilità e l’intensificazione della minaccia jihadista, la gran parte dei cooperanti ha fatto le valigie, migliaia di occidentali sono rientrati nei Paesi di origine. Le ambasciate europee hanno esortato gli “espatriati” a non correre rischi. Molti progetti sono stati bloccati e con essi la catena degli aiuti. Ma alcune realtà associative hanno deciso di restare in Burkina, portando avanti con il personale locale progetti di sviluppo, oggi più che mai necessari alla popolazione chiamata ad affrontare un’emergenza umanitaria di proporzioni paurose. Tra queste c’è l’ong italiana Tamat, con sede a Perugia, che opera da vent’anni in Burkina Faso su progetti di cooperazione internazionale. Da poco ha concluso il progetto “RASAD (Reti d’acquisto per la Sicurezza Alimentare con il supporto della Diaspora burkinabé d’Italia)”, un progetto che ha sostenuto la popolazione burkinabé più povera e vulnerabile nel perseguimento dello sviluppo socio-economico per aumentare la sicurezza alimentare, fino alla reintegrazione socio-economica della diaspora burkinabé d’Italia.
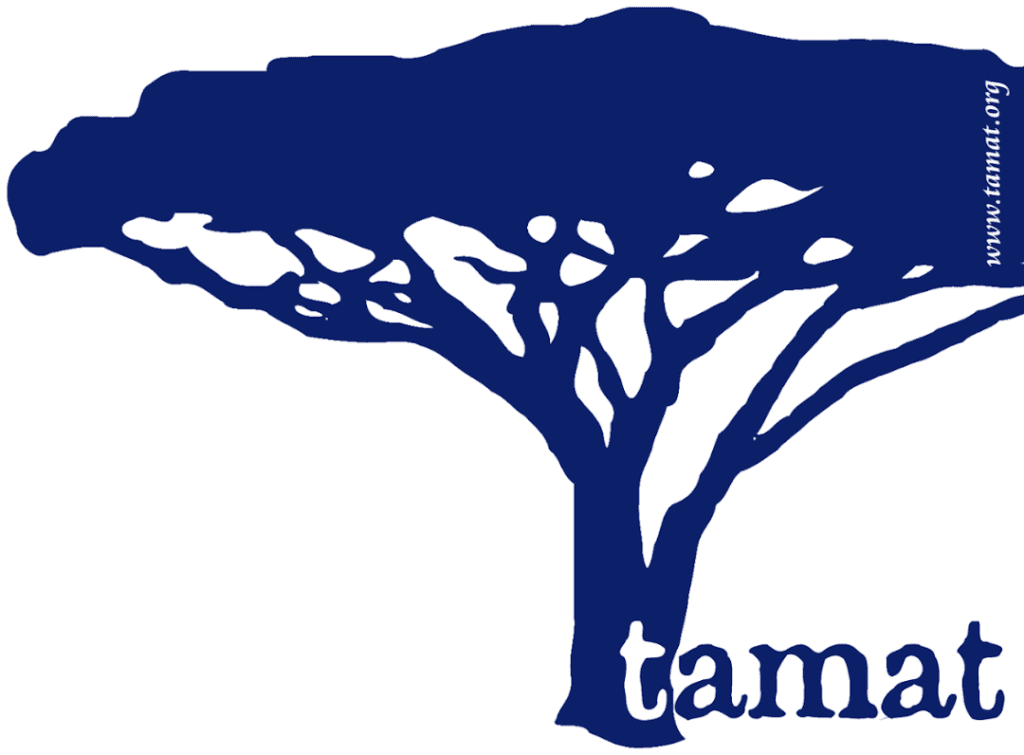
Attualmente coordina i progetti “LAPIN – Sviluppo della filiera cunicola e dell’agro-ecologia familiare: iniziative di lotta contro l’insicurezza alimentare e l’esodo rurale in Burkina Faso”, progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri italiano, che supporta l’allevamento di conigli e l’attività agricola familiare per creare nuove opportunità d’impiego finalizzate al rallentamento dell’esodo rurale e dei flussi migratori e rafforzare il ruolo della donna, e “Polli a Loumbila, allevamento contrattuale e agricoltura familiare: sostegno alle resilienza delle popolazioni più vulnerabili di Loumbila”, che opera nel contrasto all’insicurezza alimentare attraverso il sostegno all’allevamento e all’agricoltura familiare di sussistenza, creando integrazione tra allevatori e agricoltori. E’ inoltre partner del progetto “PICAPS, Progetto di approccio sistemico per il Contrasto alle cause Profonde dello Sfruttamento del lavoro minorile”, progetto coordinato da CIAI (Centro Italiano Aiuti all’Infanzia) e finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), in cui seleziona e forma 720 agricoltori su tecniche di produzione agro-ecologica facilitandone l’accesso al microcredito.




